Peterloo, ovvero l’orrore del campo di battaglia dopo la carneficina di Waterloo, replicato nella piazza St Peter’s Field a Manchester il 16 agosto 1819. Circa 60000 manifestanti si riuniscono in quella piazza per urlare il proprio diritto a una vita dignitosa, il diritto a essere riconosciuti e trattati come esseri umani e non come schiavi. Vengono ferocemente caricati dalla Guardia Nazionale a cavallo, dalla polizia e dalla Cavalleria, aizzati da un potere spietato, non per essere dispersi, ma annientati, schiacciati. Nessuno si deve permettere di sollevare il capo, di prendere coscienza di sé come essere umano, di non sottostare alle angherie del potere.
Mike Leigh, dopo il meraviglioso film sulla vita del pittore Turner, inizia a lavorare a Peterloo, il suo primo grande film storico, nel 2014. Dopo un lungo minuzioso lavoro di ricerca sui documenti, coadiuvato dalla storica Jacqueline Riding e grazie a un budget sostanzioso, addirittura insolito per lui, Peterloo viene presentato a Venezia 75, là dove ha sempre ottenuto plausi e consensi, così come a Cannes. Più volte candidato, più volte premiato (Il segreto di Vera Drake, Segreti e bugie tra gli altri).
Mike Leigh e Ken Loach sono i due cineasti britannici maggiormente attenti agli ultimi, a coloro che non hanno voce, alla quale entrambi riescono a dare dignità con pellicole a volte dure, asciutte tanto da scuotere la mente di chi guarda. I film di Leigh e Loach lasciano sempre la gola asciutta e gli occhi umidi. A volte, un senso di impotenza.
Così in Peterloo, Leigh, per buona parte dei 154 minuti di durata del film, ci racconta della sua Manchester agli inizi del 1800. Le macchine stavano cambiando l’industria e, dopo la guerra contro Napoleone, la fame e la miseria dilagavano. Giudici spietati erano capaci di impiccare un uomo per aver rubato un cappotto e la deportazione in Australia era comminata per un nonnulla.
Il film –curatissimo nei costumi e nella fotografia- inizia con una delle migliori sequenze: un trombettiere si muove simbolicamente smarrito in mezzo alla battaglia di Waterloo. Le granate gli esplodono tutt’intorno. Il fumo impedisce la visibilità. E’ disorientato. Suona la sua tromba ridicolmente, come balbettando, e nel totale disorientamento di chi non sa perché si trova in quella battaglia, la guerra finisce. Napoleone è battuto. Il trombettiere torna a casa, nella sua Manchester, là dove non troverà lavoro, ma solo fame.

I radicali però intendono muoversi contro le assurdità e le pretese angherie del potere, convocando una grande manifestazione per chiedere maggiori diritti. I giornali si schierano in favore dei manifestanti. Ma Leigh sembra sottolineare come il linguaggio adoperato dai tribuni sia distante dalla autentica comprensione del popolo. Alla gente, in fondo, interessa mettere qualcosa in tavola per sfamarsi. I paroloni sono distanti dalla loro cintola, sempre più stretta.
A lato dell’insofferenza crescente, vediamo l’arroganza del potere e, tutto sommato, anche un certo ingenuo velleitarismo nelle azioni della gente, anche se, dopo il massacro, la corona e il governo furono costretti ad alcune concessioni, segnando forse l’inizio di un nuovo corso.
Mike Leigh, come sempre, offre delle inquadarature di rara bellezza, che rasentano la perfezione pittorica; magari perde un passo nelle scene d’azione che, d’altra parte, non sono mai state nelle sue corde.
Ma non si può non ammirare e meditare su questo lungo affresco storico. Così come non si può non riconoscere similitudini in tante politiche del nostro tempo nella stessa ottusa arroganza e come non ascoltare attentamente Leigh che a domanda risponde quanto aborrisce la Brexit, che si profila, ogni giorno di più, come un disastro annunciato che coinvolgerà, volenti o no, tutti noi.
Dario Arpaio.







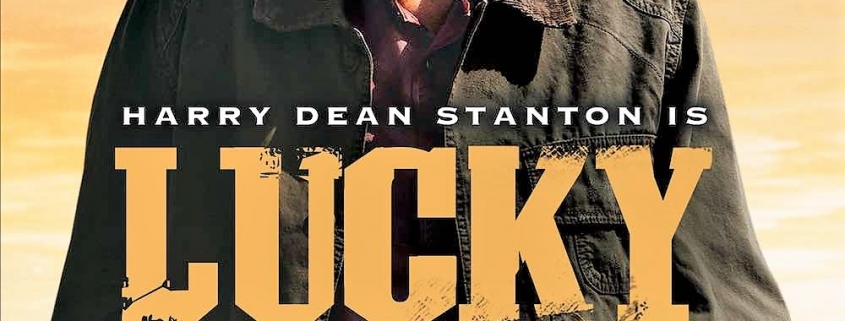



 James Gray, regista e sceneggiatore newyorkese, esordisce nel 1994 a Venezia, aggiudicandosi il Leone d’Argento per la sua opera prima Little Odessa.
James Gray, regista e sceneggiatore newyorkese, esordisce nel 1994 a Venezia, aggiudicandosi il Leone d’Argento per la sua opera prima Little Odessa.